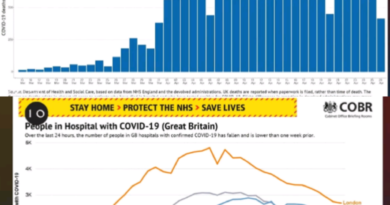Biologia e autonomia. La forza dell’istinto
di Franco Avicolli
Istinto di sopravvivenza
Credo che bisognerebbe leggere le migrazioni, il clima e l’ambiente nel senso comune dell’istinto di sopravvivenza. Esso è una non ragione per chi calcola valore e ricchezza in denaro o il benessere con le armi, i muri e i porti chiusi. E anche per la politica fatta sui bilanci e gli equilibri protettivi che non sanno né vogliono vedere in quellistinto, un’energia, una voce pressante dei momenti difficili e un fattore decisivo della vita.
L’istinto di sopravvivenza è una forza vitale, una dote grazie alla quale ogni specie costruisce le strategie per non soccombere agli eventi. Ed è un fattore attivo che si rinnova nel biotopo, lo spazio vitale in cui le strategie riescono ad avere successo proprio per il rapporto virtuoso, sinergico tra specie e territorio. Quell’istinto è alla base della storia umana, un patrimonio di esperienze, conoscenze e competenze affinate dalla sfida con la natura e dalla volontà di dominarla.
Alla luce di eventi che vanno oltre qualsiasi valutazione di parte, le migrazioni sono una realtà e lo sono le alterazioni climatiche e ambientali anche se dovessero appartenere al corso naturale della Terra e degli equilibri cosmologici. L’uomo ha costruito il proprio destino proprio in un contesto di confronto e di dialogo in cui si è insinuata anche la demagogia sviante. Per ovviare a tale pericolo è necessaria la soggettività, la consapevolezza del problema. In tale opportuna funzione va collocato il ruolo di Greta che non va considerato in senso scientifico, ma come strumento per la costruzione di una coscienza e per il coinvolgimento dell’ambiente giovanile ora soggetto di tale problematica.
Territorio e autonomia
Le esigenze del sistema liberale e la velocità della tecnica hanno relegato sullo sfondo la convivenza e lambiente, il contesto nel quale l’uomo è protagonista del proprio destino. E da qui lanimale che è in ognuno di noi e da qui chiama nello stato essenziale del pericolo, dove l’istinto è pura domanda. E un animale entrato nella storia, non può prescindere dalla coscienza di cui è dotato e sa quindi di avere bisogno dell’uomo e del suo libero arbitrio per continuare a vivere. Invita al dialogo con il territorio che è storia e biologia, a ristabilire un rapporto con l’istinto di sopravvivenza, a liberare l’energia ingabbiata in un progetto condizionato da un sistema che sacrifica la convivenza alle esclusioni.
Auspicherei, perciò, la definizione delle autonomie regionali e delle autonomie in genere sulla base del dialogo tra uomo e territorio, nella consapevolezza che esso è fonte e depositario di conoscenze, competenze, cultura, congiunzione tra le leggi della biologia e la coscienza storica. E il passaggio necessario per riproporre la centralità dell’uomo sulla base di valori come la lingua e la cultura, convivenza e conflitto, città e campagna, competenze, abilità, simbologie referenziali, fame, ricchezza e tutto ciò che definisce l’identità come condizione e progetto. E ciò che caratterizza il territorio non solo geograficamente ed amministrativamente, ma anche in senso culturale e conoscitivo. Sono questi i criteri sui quali è possibile costruire davvero l’autonomia da intendersi pertanto come partecipazione attiva alla complessa problematicità del nostro tempo fatta più di percorsi che di traguardi e di modifiche comportamentali inconcepibili senza consapevolezza.
Perché per quanto la sostanza non il corredo – dei problemi climatici sia parte di cicli epocali della Terra, le migrazioni sono dati reali, come lo sono le questioni demografiche. Le scelte locali vanno fatte in una visione generale di interconnessioni e le autonomie sono demagogia se non vengono collocate in un sistema internazionale di convivenza e della sua problematicità. E necessaria la consapevolezza che i problemi sono globali, ma le soluzioni locali.
Autonomia e umanesimo
La conoscenza e la cultura sono fattori decisivi per la costruzione di un sistema internazionale di convivenza che, per rimettere l’uomo al centro della storia, deve partire dalla problematicità dellattuale struttura piramidale per poterla superare. Si tratta di un approccio in cui il ricorso allintelligenza, alla conoscenza e alla cultura come discorso laico della speranza è alternativo al mantenimento dello status quo quale che sia. La prospettiva umanistica è possibile solo riscrivendo il presente. Ora.
In questo il contesto si definiranno nei prossimi decenni gli schieramenti e i profili politici non diversi, nella sostanza, da quelli del passato e comunque con ideologie che avranno come riferimento la conservazione e la trasformazione. Ma nella coscienza che pensiero convergente e conservazione cozzano con l’istinto di sopravvivenza, come sembrano dire le problematiche ambientali e climatiche e le condizioni di vita della maggioranza della popolazione mondiale, alla radice del fenomeno migratorio.
Allora, nella nostra Italia dove il territorio è geografia e storia e Europa e mondo, il tema delle autonomie si caratterizza da subito in questi termini, ossia umanisticamente o tecnicamente, sul destino degli uomini o su quello dei bilanci, sul dialogo con il territorio o con le banche, sulla costruzione dellEuropa cuore della civiltà umanistica e solidale o sulla difesa dei confini. Ognuno di noi è in grado di fare un elenco in cui ritrovarsi e riconoscersi. E decidere. Ed è un compito necessario visti i mari e gli orizzonti nei quali si muove la politica non solo italiana.
Storia e territorio
Non si tratta, tuttavia, di riportare in vita il passato, ma di renderlo energia del nostro tempo, soggetto di consapevolezza e orientamento, di riconoscergli la forza della sensibilità culturale fatta di competenze, abilità, visioni. I valori di riconoscimento umano sono fondamentali nel progetto della convivenza perché hanno una funzione coesiva.
La ricostruzione del territorio e delle sue caratteristiche è quindi la premessa per costruire l’autonomia. La quale non può essere davvero tale se prescinde dal rapporto virtuoso tra uomo e territorio come dato culturale e conoscitivo. Un percorso autonomista di carattere amministrativo, ovvierebbe alle problematiche del nostro tempo creando le basi di una prospettiva di grande conflittualità nella scia del presente. La sua azione deve puntare alla liberazione delle forze e l’autonomia è lo spazio necessario. Il territorio non va pertanto considerato soltanto nella sua consistenza geografica, ma anche come dimensione culturale dove hanno cittadinanza i saperi e le modalità espressive.
Autonomia e città
La città è il centro della strategia che riconosce un ruolo attivo al rapporto tra biologia e territorio. Essa è il livello più alto della convivenza e la rappresentazione razionale della sinergia tra uomo e territorio, evidenza del loro rapporto virtuoso.
Per avere valenza storica, il territorio è definito dal ruolo svolto nel tempo dalla città di riferimento e dal significato che conferma questa nel valore del presente. La caratterizzazione territoriale è fondamentale per attivare gli strumenti di governo e le partecipazioni di supporto. Il modello di riferimento è il sistema industriale. Il quale, avendo bisogno dei mercati, si è dotato degli strumenti per andare oltre i limiti amministrativi dell’area di insediamento. Insieme, ha penetrato il tessuto sociale con cui si è intrecciato dettando percorsi formativi, comportamenti, attività e tutta la filiera di funzioni in grado di assicurarne il successo. Per il significato speciale e che hanno in Italia la storia e la cultura e per il loro valore fondante, sono necessarie strutture similari capaci di interagire con il sistema formativo, con le scuole, le università e le istituzioni che gestiscono i beni culturali. In questo settore della vita sociale il problema non è la conquista dei mercati, ma la costruzione di una cultura diffusa che diventi ruolo attivo nella società e nei criteri di produzione del valore e della ricchezza.
Venezia e Mestre
In tale auspicabile prospettiva Venezia e il suo rapporto con la terraferma possono diventare un modello dellautonomia.
L’unione tra Venezia è Mestre è in discussione perché molti cittadini non si riconoscono nella monocultura turistica dominante. Si tratta di una condizione che ha effetti decisivi sulla quotidianità dei veneziani e sulle loro prospettive. Ma anche su ampi settori della popolazione mestrina che vorrebbe vivere un proprio stato di maturità. Non è facile per un cittadino veneziano pensare ad una residenzialità allorganizzazione della vita – mediata in modo decisivo dal turismo. E neppure gli è possibile definire i destini familiari nella prospettiva di una vita che costringe a venire a patti con esso anche per i costi delle locazioni e delle merci.
Le ragioni del disagio sono molte. Fra tutte desidero ricordare due eventi che evidenziano in modo emblematico in che modo la scelta della monocultura turistica determina il tessuto sociale di Venezia e lo spessore della sua vita della città.
Mi riferisco al problema abitativo di Venezia che è stato affrontato scaricandolo sulla terraferma. Ossia ricorrendo ad un metodo che ha risolto tecnicamente la questione di un tetto per la popolazione espulsa, ma non il problema abitativo della città in quanto tale, che difatti è rimasto un problema. Orbene, se lunione tra Venezia e Mestre è basata sulla sussidiarietà e sulla subordinazione funzionale, è conseguente che le scelte non tengono conto di specificità e differenze, fra laltro rilevanti per il carattere lagunare di Venezia. Cè perciò da domandarsi allora se scelte che non tengono conto di specificità qualificanti, possano produrre una qualità altra.
Dal punto di vista culturale che pure caratterizza Venezia come città, ricordo che a Venezia esisteva la Fondazione Gramsci. Questa era espressione non solo di alta cultura, ma di un’istanza del quotidiano della città di cui era un vero è proprio polmone: faceva respirare l’ambiente ed era riferimento delle università che in tale struttura trovavano un interlocutore per la sua capacità di portare i docenti e le vita universitaria oltre l’accademia. Ebbene quella struttura non esiste più ed esiste invece la Fondazione Pellicani che fra laltro opera a Mestre e si occupa della politica intesa come gioco e non come pensiero. Fra l’altro, non mi pare che le università e le istituzioni culturali veneziane, alcune di grande prestigio internazionale, abbiano un ruolo attivo nella vita della città se non per una loro storica rappresentatività. Insomma, cè un’assenza di soggettività, di protagonismo che denota larrivo e non la partenza che pure sarebbe necessaria visti i gravi problemi della città e della laguna.
Ci sono ragioni serie per considerare la separazione o lunione tra Venezia e Mestre non nel senso di ciò che esiste, ma di ciò che manca e non consente a Venezia e a Mestre di esprimere compiutamente le loro potenzialità da recuperare sulle rispettive specificità.
E paradossale far credere che in unepoca caratterizzata dalla multinazionalità produttiva la separazione aprirebbe problemi di gestione per enti strutturati sull’unità.
Il caso di Venezia e Mestre è un problema di anima, di corrispondenza virtuosa tra uomo e ambiente, di identità intesa come dialogo temporale e spaziale fra l’uomo e il territorio, di mortificazione di quella che letologo Lorenz chiama eredità cumulativa, di una energia annullata dallassenza di progetti, di una specie di istinto culturale formatosi nel tempo e ora sacrificato alla monocultura turistica.
Venezia e anche Mestre e la terraferma – ha una sua energia vitale da intendere come valore divenuto civiltà dellacqua, un complesso di conoscenze, competenze, abilità e cultura. Ma è prigioniera di un progetto che trasforma la città darte e di bellezza, di sistema di convivenza, in un luogo di osservazione e di incontro alimentato da interessi di un mercato volubile e non dalla specificità di Venezia.
Per cui la città, definita dalla sua grande valenza culturale, funziona poi su un meccanismo che prescinde dalla città dacqua come sistema di vita. E un uso indubbiamente distorto della città, ma è anche un modo per violentare e umiliare l’identità di una grande conquista delluomo e del suo rapporto con il suo spazio vitale: fioriscono ristoranti o alloggi congrui per una popolazione in viaggio e scompaiono le attività della stanzialità. Ciò provoca obsolescenza di competenze e di abilità fondamentali necessarie al valore culturale di Venezia.
Alla questione vitale dellequilibrio lagunare Ytali ha dedicato recentemente, un’intervista illuminante a Luigi DAlpaos che chiarisce questioni fondamentali. La questione della navigazione lagunare, il trasporto di cose e persone e i collegamenti interni della laguna, sono il grande problema dimenticato della città e sono nello stesso tempo la sua essenza: come affrontarli prescindendo dal rapporto tra città e territorio?
E un tema imprescindibile per disegnare il progetto di città. La sua mancanza è alla base del disagio che caratterizza lunione tra Venezia e Mestre ridotta ad una questione puramente amministrativa che ovviamente penalizza il senso di Venezia, soprattutto, e il suo ruolo.
Il tema è di grande importanza per affermare Venezia come civiltà dellacqua e come modello culturale e scientifico di un territorio che lautonomia potrebbe esaltare.
Il metodo amministrativo che caratterizza l’unione tra Venezia e Mestre appare come un modo per ovviare al grande problema di un progetto per Venezia e per Mestre. E il convitato di pietra ed è la questione che mette in crisi l’unione.
E nessuno è in grado di dimostrare che non sia una sua creatura e del modo in cui la città è ed è stata amministrata.
Credo che siano ragioni sufficienti per dubitare della virtuosità del matrimonio e per tentare altre strade.