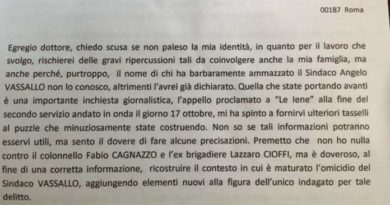Il sistema Falcone a rischio
di Francesco Bertelli
E’ arrivata da poche ore la sentenza con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha respinto il ricorso dell’italiano contro la sentenza Cedu sul cosiddetto ergastolo ostativo del 13 giugno 2019.
Che cosa è l’ergastolo ostativo? Consiste nel carcere a vita senza alcun tipo di sconti di pena né di benefici (svolgimento del lavoro fuori dal carcere, permessi premio, misure alternative alla detenzione) che in Italia viene applicato per reati gravissimi come l’associazione mafiosa, il terrorismo, nei casi in cui il condannato non collabori con la giustizia. Viene regolato dall’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario. Contro di esso aveva fatto ricorso un detenuto italiano, Marcello Viola (condannato per omicidi plurimi, occultamento di cadavere, detenzione di armi ) a cui erano stati respinti due permessi premio e anche la libertà condizionale. Nel giugno del 2019 la Corte europea aveva dato ragione a Viola, stabilendo che l’art 4 bis violava l’art.3 della Convenzione europea sui diritti umani.
Nonostante già più volte l’ergastolo ostativo sia stato ritenuto conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tendenziale finalità rieducativa della pena, con questo ulteriore pronunciamento, rigettando il ricorso dell’Italia, la Corte di Strasburgo ha di fatto sancito che l’Italia deve cambiare la sua legislazione in termini di ergastolo ostativo , nella fattispecie l’art 4 bis perchè contrario ai principi dell’art.3 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e di fatto non subordinando più i benefici carcerari alla collaborazione con la giustizia.
E’ inutile girarci intorno. L’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario si incardina con il regime del 41 bis, un’invenzione tanto voluta da Giovanni Falcone e da Paolo Borsellino, i quali , per vederlo diventare legge, dovettero essere sacrificati nel patto scellerato tra pezzi dello Stato e Cosa Nostra. E non possiamo far finta di non notare che proprio quel patto, la Trattativa, sancita da una sentenza di primo grado e da altre sentenze definitive, ha avuto come punto centrale la richiesta di Cosa Nostra allo Stato dell’abolizione dal carcere duro ai mafiosi. Su questo si è giocata la partita. Su questo sono state seminate stragi e vittime innocenti.
Capire come e perchè è nato il regime del 41 bis , ci aiuta anche a capire il suo legame con l’art 4 bis dell’ordinamento penitenziario che oggi Strasburgo ci chiede di abolire o riformare.
Occorre allora tornare sempre a quel terribile 1992: subito dopo la strage di Capaci che costò la vita a Giovanni Falcone, a Francesca Morvillo e a tre uomini della scorta, il Governo decise di introdurre il decreto-legge 8 giugno 1992 n.306, il cosiddetto Decreto antimafia Martelli-Scotti. Tale decreto venne poi convertito in legge l’8 di agosto del 1992, quasi un mese dopo l’assassinio di Paolo Borsellino e di cinque agenti della sua scorta.
Cosa prevedeva questo decreto in estrema sintesi? Consentiva al Ministro della Giustizia di sospendere per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica le regole di trattamento e gli istituti dell’ordinamento penitenziario nei confronti dei detenuti facenti parte dell’organizzazione criminale mafiosa. Tale regime si applicava (e continua ad essere applicato tutt’ora) a singoli detenuti ed è volto a ostacolare le comunicazioni degli stessi con le organizzazioni criminali operanti all’esterno, i contatti tra appartenenti alla stessa organizzazione criminale all’interno del carcere e i contrasti tra gli appartenenti a diverse organizzazioni criminali, così da evitare il verificarsi di delitti e garantire la sicurezza e l’ordine pubblico anche fuori dalle carceri. Fu così che moltissimi mafiosi tenuti in carcere vennero trasferiti a Pianosa e all’Asinara sotto il regime del nuovo 41 bis.
Fin qui tutto normale, nell’apparenza. Il problema sta nel fatto di comprendere dove nasce l’idea di abolirlo o alleggerirlo. E’ qui che dobbiamo renderci conto di un argomento che va a braccetto con il 41 bis: la Trattativa fra Stato e mafia. Non presunta, come molti continuano a farci credere. Ma reale, sancita da sentenze passate in giudicato. Occorre ricordarsi quali erano i punti del famoso papello di Totò Riina consegnato a Vito Ciancimino nel periodo a cavallo tra la strage di Capaci e quella di Via D’Amelio. Tra le richieste che il Capo dei Capi scrisse all’ex sindaco di Palermo e uomo di allaccio tra la mafia e gli apparati dello Stato, vi era proprio l’abolizione del 41 bis.
E’ da qui che poi sono iniziate le varie pressioni istituzionali che nel 1993 portarono alla nomina di Conso come Ministro della giustizia al posto di Scotti: il primo fautore di una linea più morbida con i boss mafiosi rispetto al secondo. Fu in questo periodo che per oltre trecento mafiosi fu revocato il 41 bis. E in quest’ottica dopo che lo Stato si era fatto sotto, nel senso di andare in contro alle richieste di Cosa Nostra, ci fu l’esigenza di entrare in un nuovo periodo di terrore: le stragi del 1993 al patrimonio artistico italiano.
Con la creazione della figura del collaboratore di giustizia , ideata da Giovanni Falcone, le inchieste durante gli anni 90 fino al primo decennio degli anni 2000 ha prodotto risultati investigativi incredibili. Il pentito, che collabora con lo Stato e che di conseguenza entra nel programma di protezione, ottiene già dei benefici previsti dallo stesso 41 bis. Ma di questo ,forse, i giudici di Strasburgo non ne hanno tenuto conto. E’ chiaro che spezzare questo legame , sostenendo che l’art 4 bis non è più subordinato alla concreta collaborazione con la giustizia del detenuto, si va a rinforzare la figura stessa dei detenuti legati indissolubilmente con Cosa Nostra (basta ricordare quanto comandava Totò Riina dal carcere, pur essendo al 41 bis, programmando pure la condanna a morte del magistrato Nino Di Matteo)
Chi è mafioso , rimane tale per tutta la vita. Se sa che può uscire prima o poi dal carcere, è evidente che farà di tutto per non collaborare, stringendo i denti qualche altro anno prima di vedersi riconosciuti i benefici senza doversi pentire.
Il pronunciamento di Strasburgo non ha un effetto vincolante sull’Italia, semmai spingerà i Paesi membri del Consiglio D’Europa a modificare le loro rispettive legislazioni nazionali in linea con il pronunciamento della Corte. Sarà invece determinante e vincolante la sentenza del 22 ottobre della Corte di Costituzionale italiane che sarà tenuta a pronunciarsi sul caso di Sebastiano Cannizzaro, condannato per associazione mafiosa. Lì sarà fondamentale la decisione sull’ incostituzionalità o meno della carcerazione senza riconoscimento di permessi premio.
Con questa sentenza , nonostante il trasversale grido allo scandalo da parte del mondo politico, molti garantisti e negazionisti sul tema della “Trattativa “ (sempre troppo spesso ancora definita come “presunta) festeggiano. Prima si innalzano Falcone e Borsellino come simboli dell’antimafia, ma poi sotto sotto si è contenti che i loro insegnamenti vengano pezzo per pezzo smantellati, alla luce di un’antimafia sempre più fondata solo sulle parole che sulle azioni concrete. Negare l’esistenza di un patto scellerato tra Cosa Nostra e lo Stato nel biennio 1992-1994 coincide con il voler “ri-armare” i boss dal carcere togliendo loro quel muro invalicabile e scalabile solo attraverso la collaborazione dello Stato. Un sistema che Giovanni Falcone aveva ideato negli anni ’90 , avendo capito realmente la mentalità mafiosa, e che oggi si rischia di smantellare, mandando a compimento il primo punto del famigerato papello, centro nevralgico su cui iniziò la stagione più terribile del nostro recente passato. Strasburgo, in questo senso, ci ha messo del suo.