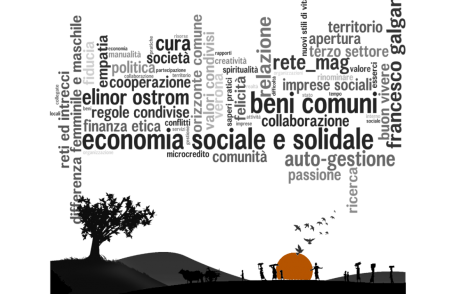Quale futuro per i BENI FUTURI?
Giusy Clarke Vanadia
Il dizionario enciclopedico Treccani definisce la locuzione “bèni comuni” come “L’insieme delle risorse, materiali e immateriali, utilizzate da più individui e che possono essere considerate patrimonio collettivo dell’umanità (in ingl. commons) in quanto risorse collettive, tutte le specie esercitano un uguale diritto su di esse…e rappresentano uno dei fondamenti del benessere e della ricchezza reale”.
Il concetto nacque in Inghilterra, nel 1.800, come conseguenza, ed in contrasto, alla scomparsa delle terre di uso collettivo delle popolazioni rurali che diede il via alla rivoluzione industriale ed al capitalismo.
Dagli anni ’70 in poi, l’economia è stata pervasa dalle pratiche neo-liberiste che, alle ingerenze dello Stato, oppone la libera concorrenza, mettendo il “profitto” al centro dei processi di mercato attraverso una politica di deregolamentazione. Si esaltava tutto ciò che è privato, in opposizione al pubblico, sinonimo di cattivo funzionamento in ogni settore. Gli spregiudicati processi di privatizzazione si sono imposti come la formula per salvare l’economia e risanare il debito pubblico. In Italia, negli anni ’90, venivano così smantellati e svenduti colossi come l’IRI, banche come il Credito Italiano e la banca Commerciale; gioielli dell’agroalimentare come Locatelli, Invernizzi, Perugina. Tutto ciò per far cassa, da versare sulla spesa corrente dello Stato, senza che su cittadini/e ci fosse alcuna ricaduta. Nonostante il perpetrarsi del saccheggio di patrimonio pubblico, il debito italiano non si è abbassato. Al contrario, dal 1970, governo Rumor-Colombo con un rapporto debito-Pil del 37,1%, è arrivato oggi al 132,1%. Incurante di questi dati, anche il presente governo conferma privatizzazioni per almeno 12 miliardi di euro.
La rivoluzione concettuale dell’idea di “bene comune”, che ha origini filosofiche, scientifiche e politiche antiche è quella di avere capovolto la visione neoliberista, per porre al centro dell’esistenza umana il diritto di fruire di beni che devono essere posti fuori dal mercato perché appartenenti a tutti.
Alla fine del ‘900 negli Stati Uniti si accese il dibattito sul concetto di “bene comune”. In
Italia esplose nel 2011, in occasione della consultazione referendaria sull’acqua pubblica lanciata da un pool di giuristi. Si trattava di quelle stesse persone che avevano fatto parte della Commissione presieduta da Stefano Rodotà che si era costituita nel 2007, e che, su richiesta del governo in carica, aveva redatto un DDL volto ad introdurre nel libro III del Codice Civile del 1942, la categoria Giuridica dei “beni comuni”. L’intento era quello di revisionare l’art.810, in attuazione della Costituzione 1948, essendo quest’ultima successiva e più moderna del Codice Civile. Fu la Commissione Rodotà a dare la prima definizione giuridica di beni comuni come “le cose che esprimono utilità funzionali all’ esercizio dei diritti fondamentali nonché allo sviluppo della persona…anche a beneficio delle generazioni future”.
Il susseguirsi di eventi climatici estremi con conseguenze devastanti di dimensioni sempre più drammatiche per l’ambiente, le infrastrutture, il patrimonio monumentale hanno riportato i beni comuni, al centro del dibattito politico e culturale anche grazie all’esplosione del fenomeno dei Fridays for Future. Secondo la definizione della Commissione Rodotà, i beni Comuni, oltre che ambientali e monumentali, sono anche immateriali come la cultura, lo spettro delle frequenze. Il testo delinea una tassonomia che, nell’impossibiltà di elencare tutti i beni, serve come punto di partenza.
Le drammatiche conseguenze della mancanza di interventi volti alla salvaguardia dell’immenso patrimonio italiano di beni comuni unico al mondo da parte della classe dirigente del nostro Paese, sono sotto gli occhi di tutti.
Due esempi emblematici, da nord a sud.
Le immagini di Venezia sommersa dall’acqua, in un fenomeno di dimensioni mai viste, hanno fatto il giro del mondo accompagnate dalle denunce della realistica minaccia della sua scomparsa, se non si correrà ad immediati radicali interventi. Ciò ha portato a riparlare del faraonico progetto del Mose, risalente a 40 anni addietro, che a 16 anni dal suo avvio con un costo, ad oggi di 5 miliardi di Euro, non è ancora stato neppure collaudato. Una storia tutta italiana di sprechi, sperpero di danaro pubblico, mancanza di trasparenza, guadagni illeciti e scandali giudiziari.
A sud, in Val di Noto, il 7 agosto scorso, si apprende che la compagnia texana Panther Oil che nel 2007 non era riuscita ad ottenere autorizzazione a trivellare per estrarre idrocarburi, anche per il forte intervento di Andrea Camilleri, riceve autorizzazione dal governo regionale. A poco è servita la mobilitazione dei sindaci e del movimento No Triv che fin ora ha solo ottenuto la sospensione di 18 mesi. Neppure tranquillizzano le assicurazioni che l’Università veglierà su tutto il processo.
Siamo arrivati ad un punto di non ritorno, ma dobbiamo correre ai ripari. Subito.
Le tragedie di devastazione ambientale di origine quasi tutte umana, prospettano “una grave minaccia alla sopravvivenza sulla Terra causata dalla politica estrattiva
dell’Antropocene”, come afferma Antonio Gambaro.
Le soluzioni ci sono. Uno dei maggiori contributi per un “Green new deal” viene dall’economista e sociologo Jeremy Rifkin con la sua proposta di un nuovo “patto per il pianeta e per un’economia sociale”, procedendo alla decarbonizzazione globale entro 20 anni, riconvertendo le industrie, praticando l’economia circolare, non consumando suolo.
La conversione ecologica dell’economia salverà anche la bellezza del nostro pianeta, ricordando che Publio Ovidio Nasone affermava che: “La bellezza è fragile, per l’esile sostanza della quale spesso è composta, e per la volubilità del giudizio umano, che spesso cambia nei repentini mutamenti dei suoi giudizi, e nell’orientamento dei poveri interessi del momento.”